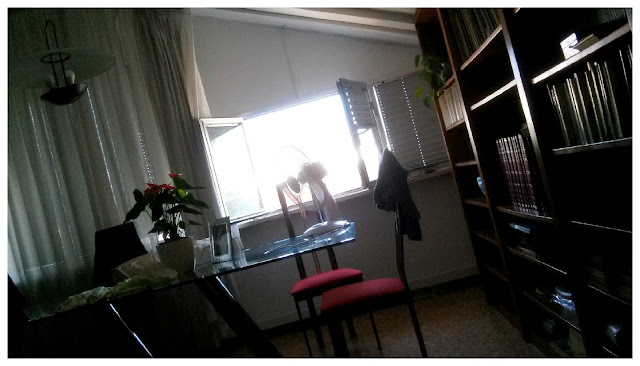Palata,
basso molise, quarantaduesimo parallelo, scossa or ora dai tremori e
i timori di un inaspettato terremoto. Lì passo da diversi anni una
parte delle mie vacanze estive. E lì ogni estate ritrovo un libro
che, scovato casualmente alcuni anni fa nella piccola
biblioteca di casa, immancabilmente rileggo con grande e crescente
piacere.
Un’abitudine fascinatoria e forse anche po’ misterica o
rituale che, mano a mano, lettura dopo lettura, estate dopo estate,
si carica di stratificate, complesse e reiterate sensazioni, e che
vive in uno spazio altro e nel tempo vacuo di un ozio che si vorrebbe
eterno, a ridosso o forse nel pieno di una crisi economica, politica,
esistenziale (epocale?) che pare non debba mai finire, fra ponti che
crollano, avveniristici, e certezze che declinano inermi, anche adesso in questo fresco luminoso e quieto pomeriggio lombardo.
Il
romazo è La Stanza del Vescovo di Piero Chiara.
Magistrale e onirica, intima e malinconica, sarcastica e avventurosa
vicenda che oziosamente si svolge nelle stagioni a ridosso della
seconda guerra mondiale sul Lago Maggiore:
fra le sue superbe ville, i
suoi misteriosi venti e le sue acque oscure... a pochi chilometri dal luogo dove casualmente vivo da diversi
anni.
***
Di
fronte a me e alle spalle di Matilde, sedevano a un tavolino come il
nostro una donna e una ragazza vestite in nero da capo a piedi,
reduci certamente dal mortorio del loro rispettivo marito e padre. La
ragazza, che non aveva più di diciotto anni, mi fissava ma come se
guardasse nel vuoto, in cerca dell’immagine paterna. Aveva i
capelli neri, un volto pallido e delicato sopra un collo lungo,
bianco e tenero, che usciva come il gambo d’un fiore dal busto
strettissimo e sicuramente marmoreo. Era il vero ritratto di
un’orfana, un po’ alla Cremona o alla Ranzoni.
Non
potevo fare a meno di studiarla. E passavo dalle impercettibili
asperità della sua fronte alla peluria scura del suo labbro
superiore, incrociandone sempre lo sguardo severo e dolce, che si
posava su di me per fuggire dalle viste dolorose, in cerca di quella
freschezza della vita che nessun giovane può lasciarsi rubare per
più d’un giorno.
Matilde,
che senza voltarsi aveva capito quale poteva essere l’oggetto della
mia distrazione, forse per distogliermi, parlò con un filo di voce:
«Quando verrà alla villa?»
«Appena
tornerò da Milano» risposi. «Fra qualche giorno.»
Dopo
quelle poche parole non ci riuscì più di avviare un qualsiasi
discorso per tutto il pranzo. Speravo di trovare una frase per
salutarla, ma non mi venne altro, mentre saliva sulla macchina, che
un banale "arrivederci presto".
Lasciai
passare quindici giorni prima di tornare a Oggebbio, dove la Tinca mi
aspettava nella darsena di Villa Cleofe. Ci andai, col battello fino
a Cannero, poi a piedi lungo la strada nazionale per non farmi vedere
dal Cavallini che non perdeva mai l’arrivo dei battelli e delle
corriere.
Camminavo,
nella bella mattinata estiva, lungo i muri delle ville, dentro e
fuori dall’ombra dei parchi, guardando in basso i barbagli del lago
ad ogni insenatura e poi l’altra sponda, nera nel controluce. Nei
tratti battuti dal sole mi investiva l’odore delle felci e delle
erbe che parevano prorompere dal fianco della montagna, tagliata
quasi a picco sul lago e gonfia di verde. Nei tratti d’ombra, al
riparo dei cedri, delle canfore o delle magnolie, sentivo il rumore
dei miei passi sull’asfalto, davanti alle soglie dei cancelli o
delle porticine ammuffite e sempre chiuse che interrompevano i muri
di cinta delle ville.
Non avevo pensieri, e mi pareva di essere un
viandante abituato alle lunghe camminate e sicuro d’arrivare ogni
giorno a qualche tavola d’osteria e a qualche letto, sempre pronto
per chi non ha casa e va per il mondo di buon animo, sicuro di
trovarlo, il mondo, sempre praticabile e qualche volta addirittura
benigno.
Arrivai
alla villa verso le undici e trovai il cancelletto aperto.
Domenico
era in giro per il parco, Martina certamente in cucina e la Lenin
forse dietro la portineria, occupata in qualche sua faccenda. Matilde
era sulla terrazza verso il lago e la raggiunsi traversando
inosservato tutto il pianterreno della villa.
Sedeva
dentro un’ampia poltrona di vimini a forma di semicupio nella mezza
ombra del glicine, vicino alle colonnine di ferro della balaustra, in
aspetto di grande abbandono, come una convalescente sulla terrazza di
una clinica. Poggiava il capo a un cuscino rosso allacciato alla
poltrona e teneva gli avambracci stesi sui braccioli, con le mani che
pendevano mollemente nel vuoto e sembravano accennare verso il
pavimento.
Girai
largo intorno alla poltrona e andai ad appoggiarmi alla balaustra. Il
suo sguardo, che vagava nel gran vuoto del lago, si ritrasse e si
fermò su di me.
«Buongiorno»
dissi. «Mi perdoni se non mi sono fatto annunciare, ma non ho
trovato nessuno dal cancello fin qui.»
Non
parve far caso alle mie parole, e senza muoversi ma sempre guardandomi
come in sogno, mormorò: «Prenda una poltrona e si metta qui, vicino
a me.»
Presi
da sotto il coperto una poltrona di vimini simile alla sua e le
sedetti di fianco.
«Dunque
è qui» disse.
E
dopo una sosta:
«Lei
saprà che l’ingegner Berlusconi è partito per Addis Abeba...»
«Non
so nulla.»
«Sì.
È partito, questa volta per sempre, dopo avermi fatto donazione
della villa con tutto quello che contiene. In riparazione, ha detto,
del danno che mi ha recato influendo così sinistramente sul mio
avvenire.»
«Allora
lei d’ora in avanti vivrà sempre qui?» domandai. «Sola?»
«Non
sola. Con Domenico, la Lenin e Martina...»
Mi
guardò intensamente ed aggiunse:
«E
con lei, se vorrà.»
Abbassai
il capo e rimasi in silenzio. Stando con gli occhi verso il pavimento
vedevo i suoi polpacci tondi incrociati e i suoi piedi un po’
larghi, calzati in scarpe strettissime. Sentivo che aspettava la mia
risposta, e che alzando il capo avrei dovuto dargliela, in un modo o
in un altro.
Provai
a immaginarmi padrone di Villa Cleofe, con la Tinca nella darsena,
Martina che al mattino mi portava il caffè a letto, Domenico che si
toglieva il cappellone di paglia quando mi incrociava nei viali del
parco, la Lena che mi serviva a tavola, dove sedevo di fronte a
Matilde.
Intanto
le guardavo i piedi e mi domandavo come potessero stare, senza
dolore, in scarpe così strette. Ma non dovevo divagare. Matilde, che
aveva ripreso a fissare il gran vuoto del lago, aspettava.
Dormire,
avrei dormito abitualmente nella stanza del Vescovo, per essere più
libero e perché sapevo che Matilde amava star sola nella sua camera:
l’aveva sempre detto, anche prima di sposare l’Orimbelli.
Il
quadro diventava completo se, da buon marito, mi vedevo al mattino o
nelle prime ore della notte traversare in pigiama il corridoio e
bussare discretamente alla sua camera.
Alzai
il capo con gli occhi rivolti verso il lago. In quel momento, dal
promontorio di Cannero spuntò come un fantasma la grande barca del
signor Kauffmann. Con tutte le sue quattro vele al vento, di un
bianco abbagliante sullo sfondo della costa lontana, la Lady passava
in silenzio. La randa, la mezzana, il fiocco e il contro-fiocco, tesi
con le mura a diritta, nascondevano tutto il soprabbordo della barca,
che sembrava deserta. In pochi minuti la Lady doppiò un altro
promontorio e sparì.
Mi
sembrò a quella vista che la grande barca del signor Kauffmann,
apparsa come una visione, fosse passata per dirmi che la vita è un
misterioso viaggio e che era tempo per me di riprendere la strada e
passare ad altri capi, ad altri porti.
Mi
alzai lentamente, mettendomi di fronte a Matilde che aveva sollevato
gli occhi verso di me.
«Me
ne vado» dissi. «Mi perdoni, ma debbo andarmene. Scendo in darsena
a prendere la barca.»
Dieci
minuti dopo uscivo con la Tinca dal porticciolo di Villa Cleofe. Era
mezzogiorno e avevo deciso di pranzare al Vittoria dal Cavallini.
Passando davanti alla villa guardai sulla terrazza. Matilde si era
ritirata. Restavano solo visibili, tra le colonnine di ferro della
balaustra, le due poltrone di vimini col poggiatesta rosso e le
frange dei cuscini che si muovevano al vento.